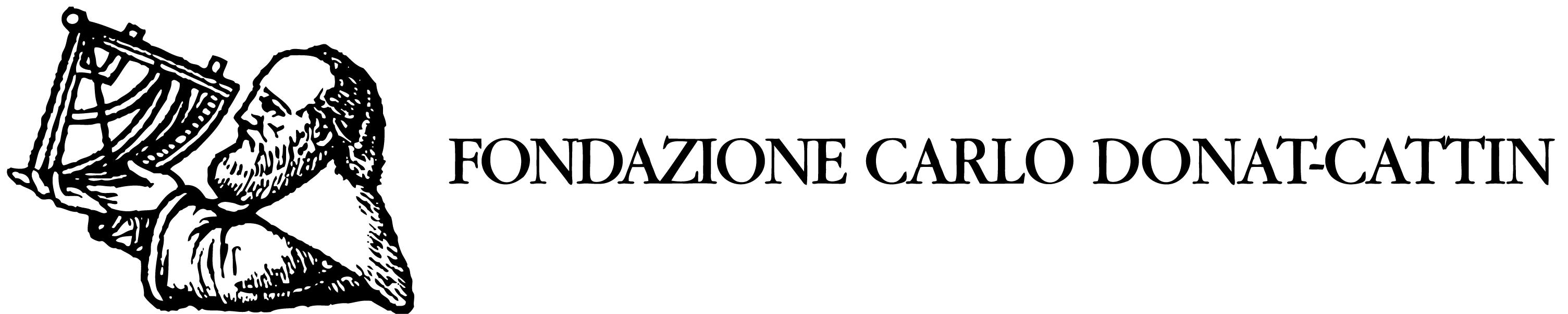La peste


Note sull’epidemia descritta da Tucidide
di Cristiana Rosella Alegiani
Presentazione
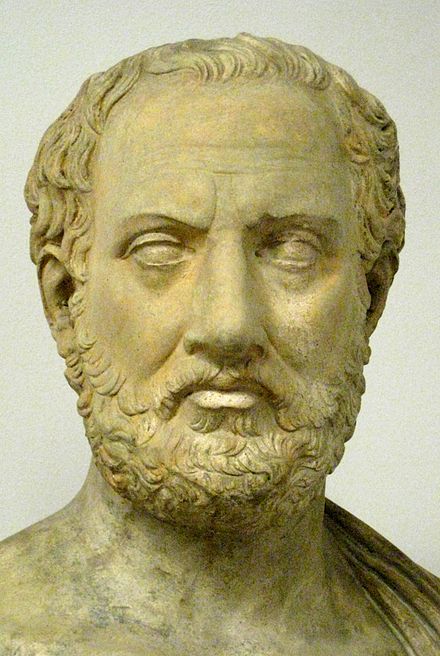
Busto di Tucidide
Dopo aver raccontato e letto La Peste di Londra di Daniel Defoe, passiamo al racconto della peste di Atene di cui riportiamo, in una versione pressoché integrale, la descrizione che ne fa Tucidide rispettando così l’ordine del nostro percorso.
Contemporaneo dei filosofi Anassagora, Protagora, Socrate e di Ippocrate, il padre della medicina occidentale, lo storico ateniese Tucidide (Atene 460/455-394 a.C.) compie nel libro II delle Storie una descrizione analitica e precisa della peste che colpisce la sua città.
Si è appena concluso il primo anno della guerra del Peloponneso (431-404 a.C.) e, subito dopo l’invasione dell’Attica (da parte dei Peloponnesi e dei loro alleati, guidati da Archidamo, re dei Lacedemoni), la peste fa “improvvisamente” la sua comparsa ad Atene. I primi a essere colpiti sono gli abitanti del Pireo e quindi gli abitanti della città alta dove il numero dei morti si fa subito impressionante.
La ragione che muove la descrizione della pestilenza è subito dichiarata: «Si dica su questo argomento quello che ciascuno pensa, sia medico sia profano […]. Io dirò di che genere essa sia stata, e mostrerò quei sintomi che uno potrà considerare e tenere presenti per riconoscere la malattia stessa, caso mai scoppiasse una seconda volta». E Tucidide assolve al suo scopo con particolare cognizione di causa perché anche lui si è ammalato di peste e ha visto altri malati. Il modo in cui descrive l’intero decorso della malattia è, nel suo crudo realismo, del tutto simile a quello di un medico.

Busto di Pericle riportante l’iscrizione “Pericle, figlio di Santippo, ateniese”
Del resto il metodo che lo storico applica in tutta la sua ἱστορία [ἡ] è molto simile a quello espresso da Ippocrate nel Prognostikón: “l’idea della prognosi, che integra la diagnosi mediante l’anamnesi, l’intelligenza del presente ottenuta mediante la ricognizione della sua genesi nel passato” e così “la scienza del passato” può anche diventare “scienza dell’avvenire”. [Pugliese Carratelli, 1967].
Eppure di fronte a questo terribile male, che colpisce anche e acutamente l’esercito perché la guerra non si ferma, i medici si dimostrano impotenti: il male è sconosciuto e quanto più si prodigano per sconfiggerlo tanto più ne sono vittime. La stessa terribile fine fanno coloro che non abbandonano i congiunti e gli amici per curarli o per seppellirli. Anche se, come sempre purtroppo, sulle consuetudini nobili e civili, persino nell’Atene di Pericle giunta a un alto grado di civiltà politica, filosofica e artistica si verifica un grave cedimento dei valori civili. Così via via che la pestilenza infuria e sembra non lasciare spazio alla vita prevalgono comportamenti trasgressivi, spesso anche iniqui, di certo non rispettosi delle leggi umane e delle leggi divine. E la bramosia del piacere appare l’unico antidoto possibile all’angoscia causata dall’inevitabilità della morte.
Tucidide, – che come Socrate e i filosofi suoi contemporanei pensa che è il nomos a dirigere gli uomini operanti nella storia e che è sempre il nomos a sostenerli di fronte all’imprevedibile, – non esprime giudizio alcuno; apparentemente impassibile rileva quello che accade, limitandosi a mettere in guardia i suoi concittadini su un possibile ritorno della malattia.
Il discorso pronunciato qualche mese prima da Pericle dall’alta tribuna eretta di fronte al cimitero in occasione della sepoltura dei primi caduti in guerra sembra un’eco lontana nella città «scuola della Grecia».